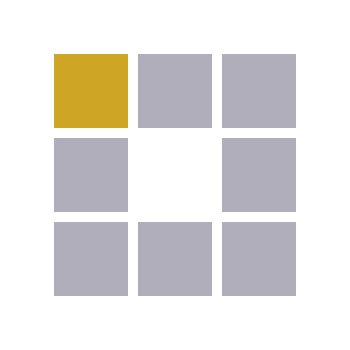Mia madre, tale e quale un musicista, si apprestava a comporre – il termine è proprio quello – 700 cappelletti, quelli riempiti di carne, con il buco al centro o con la cresta in cima, a seconda dei gusti. Dalla campagna, arrivavano le uova migliori; dalla bottega di piazza, la farina più candida. La sentivo in cucina sfrucugliare con energia in quel cratere bianco che campeggiava dal grande tavolo di marmo posto di lato al focolare acceso. 700 cappelletti da fare e… da affogare poi nel brodo di cappone: il primo piatto del 25! Il mattarello – lu stennitù, come si diceva in dialetto – passava e ripassava sulla sfoglia ocra che, al momento di essere rivoltata, risuonava con il familiare tu-tun, tu-tun. Una volta tirata senza buchi, iniziava il taglio, con l’ausilio del bicchierino da mistrà e di un coltellino. Tot rotondi, tot cappelletti. 700 – dicevamo – da far seccare tra i lini distesi sugli scuri tolti alle finestre e posti a cavallo delle sedie nella stanza più fredda. Le campane intanto segnavano la festa. Più tardi saremmo andati a messa, tutti a messa, in quella grande chiesa che avrebbe odorato di incenso, avvolta nel fascino dei paramenti sacri e della liturgia in latino. Sentivo la banda suonare per le vie del paese. I bambini correvano con mezze capriole dietro ai clarini, alle cornette e alla grancassa. Era festa di paese. Più tardi sarebbero arrivati i parenti. Ora c’era la tavola da imbandire. Mia mamma estraeva dal baule senza fondo la tovaglia più bella, quella con i fiori ricamati a mano. Piatti e bicchieri, quelli delle grandi occasioni, si materializzavano dalle credenze a muro. Il sugo intanto bolliva palpitando.
Dicono gli scrittori francesi che cucina bene, e apparecchia meglio, chi molto ama.
Dopo la funzione, e prima del pranzo, si scendeva in campagna, da quell’agricoltore che mio padre considerava un fratello. Si camminava tra i campi addormentati, guardando gli alberi, tra qualche mese pronti al frutto. Il quasi fratello e quasi zio ci raccontava dei sacrifici, della durezza del lavoro ma anche delle soddisfazioni. La terra è una dimensione dell’esistenza, è concretezza, solidità. Vigore. Infreddoliti, si passava infine per la stalla, dove l’alito caldo degli animali stazionava a mezz’aria. A destra e sinistra: mucche bianco latte, sul lato corto, di fronte all’ingresso, immancabile, l’immagine di Sant’Antonio. I contadini attendevano il freddo più intenso per la prossima salata. Era tempo di pranzo. Si tornava. A casa, nella sala buona aperta per l’occasione, oltre ai profumi dei cibi semplici e dei vini robusti, c’aspettavano le vecchie zie intente nel loro sport preferito: lo spettegolio.
22 posti, un tavolo sterminato, il nonno a capotavola eppoi via via, sino all’ultimo nato e benedetto, come una grazia di Dio. Al centro, i migliori rossi e i migliori bianchi delle Marche.
Un po’ di nostalgia del passato? Ma no, certo che no. A quei tempi c’era ancora la poliomelite, il freddo delle abitazioni procurava i geloni ai bambini, altro che termosifoni, l’acqua la si attingeva dalla fontana di fuori, il bagno lo si faceva una volta al mese, i soldi mancavano, i panni li si portava al pubblico lavatoio.
Nostalgia invece di un modo di stare insieme, di un senso della festa, del buon mangiare e del buon bere. Insomma, nostalgia del vivere. Vivere non vivacchiare diceva il santo Piergiorgio.
Ma perché “nostalgia”? La scelta è sempre nostra.
Chiederò a mia moglie di fare i cappelletti.
Mmm……..meglio che lo dica a sua madre!!!