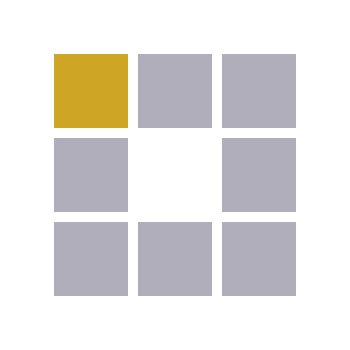Fumare? Per me é sempre stata una boccata di libertà. Ancor prima che gusto, soddisfazione, rilassamento, appagamento, tranquillità, il fumo di tabacco ha sempre significato libertà.
Libertà da cosa?
Libertà di fare, null’altro.
In un mondo regolato da stolide sovrastrutture moralistiche – seppur mascherate da salutismo e cura di sé – il fumo é stato eretto a exemplum di uno stile di vita peccaminoso e perverso, capro espiatorio sacrificato sull’altare del terrore postmoderno della morte: la lotta al fumo – con tutte le sue assurdità e supportata da studi quantitativi molto spesso perlomeno risibili – é sempre stata ai miei occhi solo la cifra della borghese incapacità di confrontarsi con la caducità dell’esistenza umana, di accettare il concetto stesso di morte. Che sia stato per reazione a questa weltanschauung, o perché irrimediabilmente corrotto dalla propaganda delle multinazionali, fors’anche per reazione ai divieti familiari, io non so, fatto sta che sono un fumatore, lo sono da anni e lo sarò fino alla mia morte.
Il fumo é libertà, dicevo. Libertà di fare. In che senso? Beh, fin da ragazzo, l’idea che una qualche attività mi fosse preclusa per qualsivoglia motivo mi ha sempre irritato! Il “vietato fumare” é senz’altro il primo divieto che ho letto: ho iniziato a fumare quando ho imparato a leggere. Non in senso letterale, s’intende, ma in senso ideologico: in un’ottica genealogica, nel divieto si radica il mio vizio del fumo. Per parecchio tempo, d’altro canto, ho fumato soprattutto per spregio ai divieti – a scuola, sul pullman, persino in ospedale.
Che fumavo?
Beh, da ragazzo fumavo sigarette! Che altro avrei dovuto fumare? Ora che fumo tabacco in ogni forma e frequento alcuni appassionati, mi capita talvolta di imbattermi in scritti o racconti di fumatori di sigari e pipa che dichiarano di non averne mai toccata una; altri dichiarano di aver caricato la prima pipa alle elementari; o, ancora, di aver conosciuto il sigaro il giorno della prima comunione, magari per festeggiare. Mah… Non so. Io mi sono cacciato in bocca la pipa per la prima volta alle superiori, ma per anni non ho tolto di tasca il pacchetto di sigarette. Al giorno d’oggi, aver fumato o fumare sigarette sembra quasi diventato un’onta… Per carità, é indubbiamente un pessimo fumo (specialmente ora), ma ognuno sarà pur libero di fumare ciò che lo aggrada? D’altro canto, é meglio arrivare alla pipa o al sigaro passando per la sigaretta o passando per i “toscani” aromatizzati? Francamente, meglio le sigarette! Queste ultime, perlomeno, hanno un lieve sentore di tabacco. Un tempo, poi, fumare Marlboro, Nazionali o Gauloises era una scelta di gusto: American Blend, contro goût français e gusto italiano. Ora come ora, gli americani hanno vinto e non esiste varietà, ma un tempo, fumare sigarette poteva essere addirittura didattico.
Ma perché mi sto perdendo in chiacchiere? Questa mia dannata inclinazione al panegirico, alla lungaggine! Fumare – dicevo – é sempre stato per me un atto di libertà: in effetti, a partire dal mio vizio, la reazione alle costrizioni é tuttora la cifra della mia modalità esistenziale. S’intende che non sono mai stato un sovversivo di gomma, come se ne vedono tanti, neppure in adolescenza: in effetti, sono sempre stato un anarchico, ma la mia é sempre stata una ricerca esistenziale. Assumere su me stesso diverse modalità di vita e di pensiero, credere in qualcosa, significava esplorare parti della mia interiorità, aspetti della mia anima sopiti e muti, se non pungolati dalle ideologie: il fluire emotivo ha sempre bisogno di una forma da assumere per esprimersi ed esistere propriamente, per quanto ridicola questa forma possa essere. Beh, la mia affettività si é a lungo dissolta in nuvole di fumo, fumo di tabacco, certo, ma non solo: quando temiamo noi stessi, tutto ci fa paura, ma, curiosamente, continuiamo ad alterare la nostra percezione, ad eccitare i nostri sensi, quasi che così facendo sia possibile uscire da se stessi. E invece ci si raggomitola, ci si racchiude all’interno del proprio piccolo mondo, ci si relega tra le fauci del mostro che si teme, quella creatura che pare sempre essere in procinto di ingoiare l’universo: il nostro io più profondo, senza dubbio il nemico più pericoloso che io abbia mai affrontato, il sacerdote più intransigente cui io abbia mai confessato i miei peccati, intransigente perché rappresentante dell’unico dio sul cui altare valga la pena sacrificare. O sacrificarsi? Lo spirito di abnegazione non mi é mai appartenuto, così come la ridicola idea di sacrificio, o rinuncia, penitenza, pentimento: ridicolaggini mediorientali. In vita mia non ho mai corso il rischio di avvicinarmi alla santità, giacché ho accumulato una quantità di peccati da far impallidire l’Agostino di Ippona prima maniera; tuttavia, io non credo che resterò folgorato come Paolo di Tarso, né che sarò protagonista di una conversione da manuale: non smetterò mai di fumare, almeno finché vivrò. Sin da ragazzo – quando ho cominciato a confrontarmi con la morte nell’unico modo possibile, con quella degli altri – ho sempre pensato che sarei morto bruciando tabacco, che sarei spirato avvolto dal profumo del tabacco che arde, possibilmente senza puzza di carta: e siccome persino nelle zone ove i malati terminali attendono la loro ora é vietato fumare, ho sempre pensato che avrei fatto di tutto per morire altrove. Magari in compagnia della donna amata. Conosco l’amore: l’ho vissuto e lo vivo! Mi abbevero a quella coppa da anni. Ho amato sin da giovane, amo e sempre amerò. D’altro canto occorre intendersi: cosa vuol dire amare? Beh, direi che non vuol dire nulla. Il significato, il perché… Stolide parole, stupide eredità lasciateci dal “che cos’é?” socratico: roba da spirito declinante. Goethe – che per me é sempre stato un punto di riferimento irrinunciabile dal punto di vista letterario – fa dire a Faust -che per me é sempre stato un punto di riferimento esistenziale – che il sentimento é tutto e che il nome non é altro che fumo: beh, concordo. A dire il vero, quando lessi per la prima volta questo passo del Faust rimasi di stucco, giacché mi resi conto che avrei benissimo potuto scriverlo io: infatti, ho sempre ritenuto le parole mero flatus voci, null’altro che latrati umani. Ci illudiamo di catturare il mondo con le nostre filosofie, salvo rendersi poi conto che sono simili a strati di smalto stesi sul nulla: non appena la natura scatena la sua forza, le nostre scricchiolanti dimore cedono. Talvolta si rimane sepolti dalle macerie, morti o imprigionati al di sotto di esse; talaltra, quando si fugge in tempo, prima che tutto crolli, si rimane all’addiaccio e il freddo della nichilistica notte attenta alla nostra salute. I più, anziché rendersi conto che non avere più pareti significa anche essersi liberati dai limiti, si fanno prendere dallo sconforto e muoiono di stenti, avendo, con il balzo salvifico che li ha tratti in salvo, solo rimandato l’inevitabile. Altri, invece, comprendono quanto é fredda la libertà, ma anche quanto é dolce il sapore del tabacco che arde in una pipa accesa sotto le stelle, nel gelo della notte. Io sono uno di questi. Ho costruito innumerevoli dimore, delineato innumerevoli modalità esistenziali e, prima di rendermi consapevole del mio ruolo di architetto, abitato innumerevoli costruzioni di senso: solo quando mi sono trovato all’addiaccio, tramortito dal cataclisma che mi aveva reso un vagabondo, ho compreso che non esistono fatti, solo interpretazioni, e che queste ultime non hanno assolutamente alcun valore. Allora, a prezzo di sofferenze e muovendomi al limite del baratro della follia, ho sentito il potere dell’intimo centro del mio essere – o dell’essere umano? -, l’affetto. Un mendicante é l’uomo quando pensa, un dio quando sente. A nulla vale la riflessione, in senso esistenziale: non é altro che un’ancella del sentire. E quando gli schiavi prendono il potere, la nazione va a rotoli: la dittatura della ragione, nella vita dell’uomo, é un male perché troppo spesso si pone in contraddizione col nostro sentire. I suoi paralogismi, i suoi sofismi non fanno altro che confonderci: prende il nostro piccolo mondo e lo riduce a vile tomba; analizza, seziona, parcellizza e, in definitiva, uccide. Il primato del sentire, del sentimento, é ben presto diventato per me un punto focale di ogni modalità di esistenza. Molto spesso però l’ho dimenticato – e tuttora mi capita di dimenticarlo: non le piccole o grandi tragedie biografiche, ma la temporanea amnesia in merito a questo mi ha talvolta precipitato in lividi inferni dello spirito, ma con indosso la maschera della salute. Ciononostante, non ho mai smesso di ardere tabacco, di fumare via le pene: l’anelito alla liberta di fare é sempre stato per me uno sprone, ben più dell’edonismo fine a se stesso. Ed ora, che mi trovo a delirare per iscritto (giacché questo é ormai evidente) – lasciando peraltro traccia indelebile di un flusso di coscienza che farebbe la gioia di molti manovali della psiche – mi rendo conto che, ancora una volta, il dio del tabacco ha voluto elargirmi un dono: un dono importante, anche se non é facile rendersene conto, e ancor meno conservarlo, non lasciarlo fuggire, non distruggerlo, bensì coltivarlo, curarlo e goderne appieno.
Sotto il grigio diluvio salutista odierno, fumare all’addiaccio é ormai pratica normale, con buona pace di chi si riempie la bocca di termini quali “tolleranza”, “convivenza” e simili: il fumatore, reietto, é costretto al freddo o al caldo, senza poter godere dei prodigi della climatizzazione. Ma, così come in metafora, anche nella realtà essere cacciati, essere gettati in strada, sbattuti fuori nel vasto mondo non é una condanna, bensì un dono. Un dono del dio del tabacco, dicevo. Ebbene, fin da ragazzino il mio vizio del fumo mi ha sempre spinto verso l’esterno, verso il mondo: un tempo erano i divieti familiari a costringermi sulla strada, ora i divieti dell’ipocondriaco stato di diritto fanno lo stesso. In un cantuccio del vasto mondo, il dio del tabacco ha voluto celare per me i suoi doni, rinvenuti mentre nella mia pipa ardeva un’ottima miscela: grazie alle sue rune ho potuto ritrovare qualcosa che avevo perso. La nostalgia cresciuta nel nostro petto come un cancro silenzioso, é di per sé un dono, ma solo se le impediamo di paralizzarci; ha il potere di spronarci, di spingerci a ritrovare ciò che abbiamo perduto: ma affinché questo suo ruolo salvifico possa palesarsi, occorre che sia conscia, coltivata, compresa e assecondata; vissuta come cifra dell’esistenza di un viandante alla continua ricerca della propria patria, ma che desidera, in fondo, solo continuare a vagare. Se c’é qualcosa che, sin da ragazzino, mi ha sempre soffocato é la casa paterna: non in senso stretto, s’intende, ma in senso esistenziale. Ho sempre adorato perdermi nel mondo, al più trovarmi rifugi sparsi per la città o per le campagne: panchine, radure nel fitto del bosco, poco importa. L’idea di luoghi propri, dimore sotto le stelle, celate a molti e note solo a chi é, in qualche modo, simile a noi. Gettati nel mondo, per un istante infinito non più soli, contempliamo nell’altro qualcosa che anche noi nutriamo, ma che talvolta dimentichiamo e seppelliamo, travolti dalle nauseanti e stolide ragionevolezze che affollano parte della nostra giornata: quel sordo, livido dolore senza nome. D’altra parte, i nomi sono aria e fumo, ma non di tabacco: il sentimento, invece, é tutto. Il mondo é nelle mani del caso, é come il gioco di un fanciullo, e i fanciulli che giocano sono molto più violenti di quanto non sembri. Non coerceri maximo, sed contineri minimo: le lacrime del mondo sono una piccola cosa, ma, quando si mescolano alle nostre in perfetta unione, hanno in potere di riportarci presso noi stessi. Teniamo stretta questa pena, viviamola fino in fondo, giacché non di pena fine a se stessa si tratta, ma dei dolori di un parto: verrà un giorno in cui ricorderemo i momenti dolorosi benedicendoli, giacché stanno dando i natali a noi stessi, nel sentirci lacerati. Grazie ad esso sorgerà in noi qualcosa di meraviglioso, se solo ne comprenderemo la natura; qualcosa cui si possono anche voltare le spalle – talvolta senza manco accorgersene: ma se decidiamo di lasciarci andare a questo afflato, il mondo apparirà ai nostri occhi come un meraviglioso giardino nel quale potersi muovere completamente liberi. I grandi spiriti, capaci di grandi sentimenti, sono più in pericolo degli altri perché, dopo aver tanto sofferto o gioito, corrono il rischio di diventare imperturbabili, di essere vissuti più che di vivere, di aderire a un modello di vita che – seppur liberamente scelto – é pur sempre una catena, un legaccio maledetto che li costringe e direziona. Sì, si può scegliere di vivere in catene, come il cavallo che si lascia sellare, imbrigliare e montare, magari col paraocchi. Ma compatire con la propria sofferenza, condividerla anche solo per un istante, é un grande passo nella direzione opposta, verso il centro di noi stessi, laddove siamo completamente liberi, una volta zittiti i latrati del mondo: solo allora ci rendiamo conto di quanto ci fossimo allontanati.
D’un tratto, col volto rigato dalle lacrime e il cuore colmo sino a scoppiare, piegati in noi stessi come un urlo soffocato, nella più pura solitudine, non siamo soli, ma stiamo versando, insieme, lacrime di gioia! Nelle nostre profondità, stringendoci in un abbraccio che non ha bisogno di parole, non ci resta che fumare.
“Io mi ricordo ancora del bosco d’olmi che china le larghe cime dei monti sul mulino, ma nella corte cresce la pianta del fico.
Nei giorni di festa vanno le donne brune sopra un piano di seta, al tempo di marzo, quando uguali son la notte e il giorno, e sui sentieri lenti carico di sogni d’oro passa ondoso il respiro del vento: ma mi si offra quella coppa inebriante colma di luce bruna perché possa riposare. Dolce sarebbe sotto le ombre il sonno. E male è se l’anima si perde lontano da pensieri di mortali. Bene è invece parlare, dire dei giorni dell’amore, dei fatti che avvennero.
Ma gli amici, dove sono? l’amore fissa i suoi occhi fedeli. Ma il poeta fonda ciò che resta.”
(Hölderlin)